L'uso della parola Crisi non ha mai avuto crisi
 Sono passate poche settimane dal crollo della palazzina di Barletta e su questa tragedia i media hanno spento già i riflettori. Certo, se da una parte è la netta conseguenza di un giornalismo votato alla drammatizzazione, dall’altra non si può pretendere che il mondo ci pianga su per mesi e mesi.
Sono passate poche settimane dal crollo della palazzina di Barletta e su questa tragedia i media hanno spento già i riflettori. Certo, se da una parte è la netta conseguenza di un giornalismo votato alla drammatizzazione, dall’altra non si può pretendere che il mondo ci pianga su per mesi e mesi.
Ci sono però alcune notizie che al di là del fatto in sé rappresentano una condizione molto diffusa se non addirittura generalizzata. Il crollo del palazzo di Barletta è una di queste.
Possiamo indignarci (giusto per usare un termine in voga) per le perizie sbagliate, per la negligenza degli addetti ai lavori e per coloro che hanno evaso le responsabilità, ma tutto ciò farà il suo corso agli occhi della giustizia. O almeno ce lo auguriamo. Vi è però un aspetto di questo dramma che colpisce direttamente la nostra società e una delle sue colonne portanti: il lavoro.
La palazzina di Barletta, accartocciandosi su sé stessa, ha portato alla luce l’orrore di una camiceria i cui dipendenti arrivavano a lavorare più di dieci ore al giorno per una paga di pura miseria. Chiaramente tutto a nero. Un orrore a tutti gli effetti che ha mostrato al mondo una realtà lavorativa che generalmente usiamo attribuire alla Cina ma che è anche tipicamente italiana.
 Emerso l’orrore si è sollevata una ventata di indignazione che ha caratterizzato i servizi giornalistici, gli interventi in studio, i talk show e qualsiasi altro spazio dedicato al dramma. Ma una ventata è tale perché passa in meno che non si dica, lasciando alle sue spalle cumuli di ipocrisia e marciume. Si perché questa tragedia sembra essere stata salutata come un caso che i “gentiluomini” si augurano di non rivedere.
Emerso l’orrore si è sollevata una ventata di indignazione che ha caratterizzato i servizi giornalistici, gli interventi in studio, i talk show e qualsiasi altro spazio dedicato al dramma. Ma una ventata è tale perché passa in meno che non si dica, lasciando alle sue spalle cumuli di ipocrisia e marciume. Si perché questa tragedia sembra essere stata salutata come un caso che i “gentiluomini” si augurano di non rivedere.
Dagli anni Ottanta abbiamo assistito ad un proliferare di camicerie in cui norme e contratti non venivano minimamente rispettati. In genere erano la Tigerland di chi, rifiutandosi di continuare gli studi, decideva di immettersi da subito nel mondo del lavoro. Anche quando nel nostro Paese le cose giravano bene, questi lager lavorativi attraevano manodopera giovane, sfruttandola fino al midollo e inculcando loro un’idea del lavoro completamente negativa. Queste realtà si sono protratte fino ad oggi perpetuando mille imbrogli e sfruttando le contingenze più pubblicizzate (come, per esempio, la solita crisi) per succhiare altro midollo agli operai.
Il termine crisi non ha mai avuto crisi.
I governi che si sono alternati e le classi dirigenti che sono seguite ne hanno fatto sempre un uso sconsiderato. Parlare di crisi ha sempre fatto comodo poiché in questo modo si metteva in circolazione quella paura generalizzata, quell’inquietudine debilitante, che induceva i più deboli a sottostare alle logiche dei padroni. La paura serve a dominare gli uomini, come si dice nella Storia Infinita, e il termine crisi è la bacchetta magica con cui diffonderla.
Le camicerie come quelle di Barletta sono solo un tassello di un mosaico dell’orrore molto più esteso. Nell’agroalimentare, nel metalmeccanico, nell’informatica, nei servizi e in ogni altro settore, i casi in cui le norme vengono spesso sorvolate restano numerosi. Ricordiamo tutti per esempio la tragedia nello stabilimento dei tedeschi Thyssen a Torino. Persino le cosiddette multinazionali, dove una regolamentazione delle condizioni di lavoro dovrebbe essere più osservata, presentano piccoli inferni o disparità tra una filiale e l’altra, spesso tra quella del nord e quella del sud.
A proposito del sud.
Lo sfruttamento lavorativo, pur essendo una piaga diffusa in tutta Italia, è particolarmente presente al sud dove è addirittura legittimata da una serie di “valori” derivanti da logiche tipicamente feudali. Se da una parte molti imprenditori tendono ad arricchirsi sul sangue di chi lavora per lui, dall’altra gli stessi dipendenti usano alzare la voce molto di rado, poiché chi pretende norme di lavoro più rispettose rischia di passare agli occhi degli “altri” come scansafatiche o mezzacartuccia. C’è insomma un certo machismo, o masochismo a seconda del punto di vista, diffuso tra i dipendenti i quali finiscono per diventare carnefici di loro stessi.
Quindi assistiamo a imprenditori che fanno dello sfruttamento della manodopera la loro maggiore fonte di arricchimento, dall’altra ad operai e dipendenti le cui vite finiscono totalmente risucchiate e inaridite dal lavoro.
Alla luce di questi discorsi i pensieri vanno a tutti coloro che bene o male valorizzano la loro vita oltre al lavoro. Insomma, a tutti coloro che amano quotidianamente la propria moglie, o il proprio marito, i propri figli, o magari hanno delle passioni, delle aspirazioni, degli impegni, delle attività da svolgere. La nostra stessa vita, se amata, può diventare l’elemento catalizzatore che ci può spronare a pretendere, per esempio, orari più umani.
Molto spesso però accade anche che chi ha qualcosa che lo faccia sentire vivo finisce per perderlo per strada e senza accorgersene si ritrova ad assistere alla tritatura di emozioni, sentimenti, affezioni. E proprio per questo viene da chiedersi: se non siamo noi stessi a batterci per i diritti più personali, come possiamo pretendere di costruire un mondo migliore da dare ai nostri figli? E ancora, quanti altri crolli dovranno scoperchiare inferni prima che noi tutti ci svegliamo?

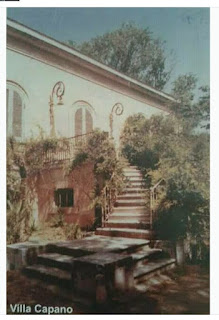


Commenti
Posta un commento